Relazione di Igiaba Scego
“Scrittori migranti di seconda generazione”, questo è il tema che Roberta Sangiorgi mi ha proposto per questo corso-convegno ed io naturalmente ho accettato entusiasta. Per la sottoscritta è stata una sorta di sfida indagare su un tema che di fatto la riguarda così da vicino. Infatti io sono proprio una scrittrice migrante di seconda generazione, nata in Italia da genitori migranti e un po’ migrante nel cuore (per non parlare poi del fisico). La mia formazione culturale è italiana, la lingua in cui scrivo è l’italiano (non per scelta, ma per corso naturale)…ma il mio vissuto è legato a doppio filo con la madrepatria del cuore, ossia quella Somalia martoriata dei miei genitori. Indagare su questo tema mi sembrava un’opportunità sia per me stessa, sia per gli altri- esperti, professori universitari, ricercatori, insegnanti, studenti, scrittori o semplici curiosi.
Ho parlato con molte persone in questi mesi, ho letto anche molto, ho girato sui siti web letterari e/o di migrazione. E sapete qual’è stata la mia scoperta? La letteratura migrante italiana non ha ancora la seconda generazione. Allora a che pro un intervento con questo titolo? Giusta domanda che merita una giusta risposta. Semplicemente possiamo essere insieme testimoni (fruitori, ricercatori) di un fenomeno che sta nascendo adesso, sotto i nostri occhi.
1) L’Italia non ha ancora un Hanif Kureishi, una Zadie Smith, una Monica Ali;
2) l’Italia rispetto a paesi come Gran Bretagna, Francia o Germania sta migliaia di chilometri indietro sul terreno dello sviluppo della letteratura migrante;
3) L’Italia ha un panorama critico-letterario che stenta a prendere sul serio i migrant writers
Ma qui nel Bel Paese -e sembra un paradosso- siamo all’avanguardia per un fatto semplice e banale all’apparenza, un fatto così semplice e banale che non è stato colto in paesi come Germania, Gran Bretagna e Francia a suo tempo. Qual’è questo fatto? Noi abbiamo la grandissima fortuna di poter studiare, analizzare, consumare la letteratura migrante fin dal suo primo vagito e questo a maggior ragione riguarda la scrittura migrante di seconda generazione. Possiamo cogliere cioè il fenomeno fin dai suoi primissimi momenti. In un certo senso è come fare una ecografia al fenomeno…prima abbiamo la fase embrionale, poi a mano a mano il feto prende forma, si ingrossa, si trasforma davanti ai nostri occhi curiosi e poi un bel giorno esce fuori dal ventre che l’ha tenuto nascosto (e al sicuro) dagli sguardi indiscreti. Ma la cosa non finisce qui, la letteratura migrante in genere e quella di seconda generazione in particolare, ha un suo sviluppo (ancora sconosciuto) anche fuori dall’ospitale ventre. Come un neonato farà i suoi primi passi, dirà le sue prime parole….crescerà, una crescita che non sarà esente da incognite, cadute, grandi crisi.
Vi parlerò di me come caso di scrittrice migrante di seconda generazione. Non è un delirio di onnipotenza il mio, anzi. Però visto che l’argomento mi riguarda molto da vicino e visto che mi conosco meglio di chiunque altro, ho pensato di essere una cavia perfetta per voi. Sarò il più sincera possibile e spero che questa testimonianza possa essere utile a più persone. Però prima di parlarvi della mia esperienza, vorrei farvi una piccola cronistoria del fenomeno della letteratura migrante.
L’Italia è diventata una delle tappe fondamentali della migrazione del terzo millennio. La sua forma lunga, affusolata, bagnata per l’80% dal mare hanno trasformato la penisola in una delle zone di transito più gettonate dai migranti. L’Italia è il ponte verso l’Europa (e anche verso l’America), è il Nord che abbaglia, che illude, che rifiuta. È il Nord ricco, il Nord che sognano i migranti, Un Nord privo all’apparenza privo di tribolazioni. Invece ahimè le tribolazioni sono poi tante una volta arrivati in questo fantasmagorico Nord. Si vede l’altra faccia, quella che la Tv non mostra, quella che i sogni rifiutano. Un Nord cattivo, che non accoglie, un Nord che dice “NO” senza dare troppe spiegazioni. Sono tanti i migranti che sognano l’Italia per poter poi andarsene altrove….verso i paesi del Nord Europa che danno sussidi, case, inserimento ai rifugiati (che “davano” dovremmo dire ad onor del vero, infatti le politiche migratorie dei paesi del Nord Europa si sono di molto ristrette rispetto agli anni 90, caso eclatante la Gran Bretagna di Tony Blair). Si dice che per l’Italia il fenomeno migratorio è un fenomeno nuovo e quando si parla di carrette del mare (usate da tanti disperati per raggiungere le coste italiane) scatta subito nei media e nell’immaginario collettivo una parola abusata e iperusata: EMERGENZA. Ma siamo sicuri che la migrazione è ancora una novità in Italia? Certo rispetto a paesi come Francia e Gran Bretagna, l’Italia ha una migrazione cominciata più tardi (anche perché prima l’Italia era terra di emigranti, verso l’America o verso Nord da Sud), ma sono ormai 30 anni che il paese è interessato da questo fenomeno. Forse non è tantissimo tempo, ma non è nemmeno poco. Parole come novità e emergenza dovrebbero essere usate con più sapienza rispetto a questo fenomeno.
Negli anni 70′ i primi migranti provenivano dall’Ex colonie italiane. Somali, eritrei e qualche etiope. Ma sono stati gli anni 80′ con il massiccio arrivo di marocchini, filippini e senegalesi a fare la differenza. Nel 90′ poi sono arrivati da tutte le parti: Europei dell’est, sudamericani, cinesi. La migrazione è diventata multiple e complessa nella sua formazione.
In Italia non c’è una prevalenza di un gruppo rispetto ad un altro. Certo ci sono più filippini che somali nel territorio, più cinesi che malesyani, più peruviani che boliviani, ma non c’è una predominanza di un gruppo sugli altri. Invece questa c’è in Francia -con i maghrebini- o in Inghilterra -con gli indiani e i pakistani. Questo multiple e complesso ha un eco anche nella letteratura migrante. Quindi questo è stato il terreno sociale dove nascono i migrant writers.
Ma esiste un momento preciso dove collocare la nascita di tale letteratura?
In realtà non si può mai dire con esattezza quando un fenomeno letterario nasce. Come non ricordare i travagli dei libri di testo scolastici nel collocare autori in un dato movimento letterario; come non ricordare quelle frasi ambigue tipo “Pincopallino, un autore a cavallo di romanticismo e decadentismo”; come non ricordare le difficoltà di trovare un anno d’inizio per i grandi movimenti letterari. I nostri libri di testo arrancavano, come del resto hanno arrancato i critici letterari prima di loro. Non si può racchiudere un fenomeno complesso in una fredda data. Un movimento letterario è fatto di tormenti, ripensamenti, caos, illuminazioni, amore. Però ciò non toglie che alcuni episodi siano stati importanti nella genesi dei fenomeni letterari. Nel caso della letteratura migrante il momento X, l’evento che ha portato ad una consapevolezza piena gli autori è stato la morte di Jerry Masslo.
Jerry -molti oggi non se lo ricordano quasi più- era un ragazzo come tanti, pieno di sogni e di passione, un giovane sudafricano che era venuto in Italia a cercare una vita un po’ più dignitosa. In Italia invece trovò una morte atroce e dozzinale, una morte degno del peggiore B-movie violento. Nella notte tra il 24 e il 25 Agosto 1989 viene derubato e assalito da una banda di ragazzi “bianchi” del luogo. Jerry muore e l’Italia sgomenta si risveglia “razzista”. Teatro della vicenda è una cittadina in provincia di Caserta, Villa Literno, una terra dove la fa da padrone la camorra, dove (e chiunque di noi può appurarlo stando comodamente seduto su un qualsiasi treno verso Napoli) l’abusivismo è una piaga quasi insanabile e dove i giovani vengono abbandonati a se stessi. Era ed è ancora un far West Villa Literno. Un paese senza quasi più speranze. Jerry e tanti come lui erano approdati lì per raccogliere i pomodori, erano stagionali pagati una miseria….stagionali pieni di sogni. In questa triste storia la vittima e i carnefici sono oppressi. La gente, i media, i politici reagirono con dolore e apprensione alla morte di Jerry. Addirittura la Rai trasmise in diretta i funerali del ragazzo. Ci furono manifestazioni, dibattiti Tv…e fu proprio dopo il caso Masslo che fu trasformato in legge un decreto sui cittadini immigrati; era la famosa legge Martelli del 1990 (ossia la prima legge che cercava di regolare il fenomeno della migrazione. Pur nelle sue numerose imperfezioni, la legge è stato il primo tentativo di colmare un vuoto nel panorama giuridico italiano. Infatti prima del 1990 tutto quel che riguardava i cittadini migranti veniva regolato dal Testo Unico di pubblica sicurezz. Una legge che faceva rima con repressione del crimine e che risaliva al periodo fascista, 1931 per essere esatti).
È chiaro che un evento del genere abbia influito sulle coscienze dei migranti.
Il primo a reagire è stato Tahar Ben Jelloun, con un saggio-acconto Villa Literno (il racconto si trova nel libro Dove lo stato non c’è. Racconti italiani-1991. Libro scritto in collaborazione con Egi Volterranni scrittore/giornalista).
Questo unito ad un sempre più interesse verso il fenomeno migrazione hanno dato il la a questa nuova letteratura. Sorsero come funghi programmi TV che parlavano di migrazioni, i giornali e le riviste cominciarono ad interessarsi a questo fenomeno e soprattutto i grandi editori scesero in campo. Infatti i grandi editori avevano odorato “l’affare” dietro il nuovo fenomeno e avevano i mezzi per poterlo diffondere. Il caso Ben Jelloun-Volteranni (orchestrato molto bene dall’Einaudi) aveva dimostrato che una letteratura esotica-impegnata poteva rendere e vendere. I primi anni 90′ hanno visto così la nascita di molti testi migranti e per case editrici di tutto riguardo. Ricordiamo alcuni titoli:
Pap Khouma-Senegal-Io venditore di Elefanti (1990)
Mohame Bouchane-Marocco- Chiamatemi Alì (1990)
Salah Methnani-Tunisia- Immigrato (1990)
Saidou Moussa Ba-Senegal- La promessa di Hamadi (1991)
Moshen Melliti-Tunisia- Pantanella, canto lungo la strada (1992)
Cosa avevano in comune questi testi? Naturalmente l’autore migrante, poi spesso erano racconti sulla esperienza dell’immigrato in prima persona e infine la tecnica di scrittura. L’italiano di questi testi era fluente, classico, privo di errori. Com’era possibile questo? Com’era possibile che autori che avevano appena imparato la lingua, la padroneggiassero così bene? In realtà gli autori erano molto bravi di loro, ma erano in fase di redazione coadiuvati da un autore italiano, una sorta di editor factotum. L’autore si fa portare e questi primi scritti migranti hanno un discreto successo.
Ma poi?
L’esotismo migrante a dirla come un rappresentante di una grande casa editrice non tirava più. I Colossi abbandonarono la migrazione e gli scrittori furono costretti a trovare altre strade. È un momento delicato, un momento di crisi, un momento che può decretare la morte di un fenomeno appena nato. Ma invece di perire la scrittura migrante trova una via nuova, originale. In poche parole il più grosso ostacolo è superato; ai vecchi autori se ne aggiungono nuovi…e la letteratura va avanti.
Il più grande cambio è proprio negli autori. Si approda ad una scrittura più matura, più attenta; si abbandonano i co-autori, si scrive direttamente in italiano senza più bisogno di intermediari, non si ha più paura di sbagliare, si abbandona l’autobiografismo stretto (da vedere in questo senso il secondo libro Moshen Melliti). Inoltre cosa importantissima la letteratura migrante comincia a percorrere strade meno note, forse più accidentate, ma importanti ai fini della sua stessa sopravvivenza. La letteratura migrante comincia ad accompagnare la sua vita a quella del volontariato, a quella delle numerose organizzazioni sociali come Arci, Caritas, mani Tese e ONG meno conosciute. Inoltre una importanza sostanziale l’avranno anche riviste quali Nigrizia, Terre di Mezzo, Tam-Tam e case editrici che si occupano di intercultura come Fara di Rimini o Sinnos di Roma. Nascono anche premi letterari per scrittori migranti come Exs&tra e riviste totalmente migranti (e storia dei nostri giorni) come El-Ghibli.
Il fenomeno è in movimento. Gli autori si sono triplicati. E ora cominciano ad esserci anche studi seri sul fenomeno.
Purtroppo su questa ultima nota-lo studio- dobbiamo sottolineare anche un certo ritardo della penisola. Sembra un paradosso, ma in Italia (parliamo del mondo accademico) nessuno quasi si interessa di letteratura migrante. Le cattedre di italianistica la snobbano come fenomeno passeggero e gli studenti la ignorano completamente. Una materia letteraria come questa è stata adottata da studi non direttamente legati alla letteratura: la sociologia, l’antropologia, la pedagogia interculturale. Non è un caso che uno dei più interessati a questo fenomeno il prof. Armando Gnisci (la Sapienza, Roma) sia un comparatista. Invece- ed è questo un paradosso ancor più grande del precedente- il fenomeno è studiato molto oltreoceano. Spesso sono i figli o i nipoti degli emigranti italiani a guardare alla letteratura migrante italiana, agli stranieri che usano l’italiano come lingua di scrittura, una sorta di specchio di quello che è successo ai loro padri e ai loro nonni…..ma proprio nel paese dei loro padri e dei loro nonni. Ed ecco che negli USA, in Canada, in Australia perfino è un fioccare continuo di ricercatori che si avvicinano a questo movimento.
Ed è qui che entro in scena io, la scrittrice di seconda generazione.
Non credo di essere ne la prima, ne la più brava, ne la sola. Sono sicura che da qualche parte ci sono altre persone come me (e sempre di più ce ne saranno in futuro, basta vedere quanti bambini di origine straniera affollano le aule italiane). Alcune le conosco, altre vorrei conoscerle.
Cosa fa di me e dei miei pochi compagni (pochi ancora per poco) così diversi dagli scrittori di prima generazione?
Prima di tutto la nascita. Spesso gli scrittori di seconda generazione sono nati qui, nel Bel Paese. O se non sono nati, ci sono venuti da molto piccoli (pochi della decade 70/80 sono frutto di matrimoni misti). Siamo figli di quella generazione di migranti approdata in Italia negli anni 70/80. Abbiamo frequentato le scuole italiane, abbiamo avuto una formazione culturale italiana, abbiamo vissuto parte della nostra vita in un habitat italiano (dico parte perché la casa per uno scrittore di seconda generazione non è un habitat italiano o lo è solo in parte). Quindi siamo italiani in tutto e per tutto. Non siamo diversi dai vari Andrea, Luca e Gaetano. Abbiamo visto l’Italia vincere i mondiali di calcio dell’82, Abbiamo fatto una sana overdose di cartoni animati giapponesi come ogni ragazzino italiano che si rispetti (da Capitan Harlock a Lady Oscar, passando per l’immancabile Lupin alla riccioluta Candy Candy ), abbiamo visto anche Tiziana Rivale vincere il festival di Sanremo, prima che scomparisse dalla circolazione. Però in noi c’era una differenza, la nostra origine migrante. Abbiamo succhiato con il latte materno mondi lontani, esotici che però ci appartenevano nell’intimo. Nel caso mio era la Somalia: a casa vivevo la cultura somala e la religione islamica. Parlavo il somalo, mangiavo il cibo somalo, facevo le preghiere ad Allah e non a Gesù. Vivevo di fatto una scissione, una scissione che soprattutto nell’infanzia è stata piuttosto conflittuale. Non capivo tante cose da piccola e poi vivevo fuori dalle mure domestiche quella cosa immonda chiamata razzismo. I neri-e in generale- gli stranieri erano pochi all’epoca e devo dire che in quei primi tempi i miei genitori e poi di riflesso io (a scuola soprattutto) abbiamo dovuto affrontare i peggiori insulti. Questo mi ha portato a negare la Somalia, volevo rigettarla e volevo avere la pelle bianca come gli altri. È interessante in questo senso quello che ho scritto nell’introduzione al libro per ragazzi la nomade che amava Alfred Hitchcock che ho pubblicato nel 2003 (Ottobre) per la Sinnos editrice:
“La Somalia è stata una meteora nella mia vita. Essendo nata in Italia all’inizio non riuscivo proprio a capire che fosse questa Somalia e francamente ne avevo molta paura. Avevo sviluppato una fantasia personale sul mio paese d’origine: credevo fosse un paese rosso, una sorta di Marte terrestre. Fu grande la mia delusione quando, all’età di 8 anni, mi accorsi che la Somalia non era rossa come Marte, ma aveva gli stessi colori dell’Italia. La delusione iniziale durò un attimo. Infatti scoprii che la Somalia era un paese meraviglioso dove l’uomo poteva vivere felice in simbiosi con la natura. Adoravo (e adoro) la mia bella Roma, ma Mogadiscio mi ha dato l’opportunità di recuperare le mie radici e di ampliare il mio orizzonte culturale.”
Non so quando ho cominciato a scrivere, scribacchiavo dovunque. Diciamo che ho cominciato a scrivere “seriamente” solo dopo la fine dell’università Il mio primo approccio alla scrittura è stato il giornalismo. Scrivevo recensioni, articoli sulla realtà migrante, schede. Una scrittura funzionale, asettica, controllata. Ho tentato di introdurmi nel mondo del giornalismo, ma ho dovuto (come tanti prima di me) affrontare un mondo chiuso, d’elite e di raccomandazioni. Inoltre -cosa più importante- quel tipo di scrittura (che ha una sua nobiltà, non a caso continuo tutt’ora quando mi capita) non mi soddisfaceva del tutto. Volevo spaziare, dare estro alla mia fantasia, alla mia voglia di libertà rispetto agli schemi classici di un articolo di giornale. Fu così, quasi come una sfida, che cominciai con la narrativa. Le mie prime cose erano davvero inguardabili, illeggibili….in una parola brutte. Un giorno decisi di mandare un mio scritto ad una piccola casa editrice di Viterbo. Era uno scritto su un travestito e una ragazza somala che avevano una passione comune per i Beatles. Il tutto era un guazzabuglio orribile su storia dei Fab Four, seghe mentali dei protagonisti e frase fatte prese da film famosi. Orribile. La piccola casa editrice di Viterbo mi inviò una lettera. Non la solita lettera impersonale di rifiuto, ma una lettera “viva” di rifiuto. Il signore della lettera mi spiegò il perché il testo non andava….un massacro che presi piuttosto male all’epoca. Ma in tanti giudizi negativi il signore di Viterbo (che aveva ragione su tutto!!!) mi scrisse anche “signorina non molli. Lei ha del talento”. Io non so se ho del talento o meno, ma so di avere tante cose da dire…anche all’epoca avevo tante cose da dire, ma mi mancavano gli strumenti. Dopo un periodo (breve) di abbandono della scrittura, cominciai a scrivere piccole storie. I miei protagonisti erano spesso uomini, spesso lontani anche storicamente da me. Ricordo un raccontino su un nazista innamorato di una zingara, ispiratomi da una canzone di Joan Baez. Poi la mia grande svolta arrivò una sera. Ero stanca e arrabbiata. Un controllore di autobus mi aveva trattato come una ladra solo perché non trovavo la tessera (tessera che trovai all’ultimo, evitandomi per fortuna la multa). Mi disse qualcosa come “voi negri siete tutti ladri”. Una litigata che non vi dico. Tornai a casa triste e cominciai a scrivere. Quel racconto divenne Salsicce, ossia il racconto che mi ha portato tanta fortuna facendomi vincere il premio per scrittori migranti Exs&tra 2003. In Salsicce il tema dell’identità è predominante. Lo sarà anche in altri racconti editi-come La strana notte di Vito Renica, leghista meridionale, pubblicato proprio ora sulla rivista El-ghibli- e inediti. In In Salsicce parlo di un’identità multipla che viene messa in crisi dalla legge Bossi-Fini. Ne La strana notte di Vito Renica, leghista meridionale, rappresento un personaggio, un napoletano, che nega la sua identità e se ne costruisce un’altra, spinto dalla pressione politica, perché vuole essere un leghista. In Salsicce dico una cosa che ogni volta mi meraviglia:
Credo che questo dissidio lo vivano molte persone (e non solo scrittori) di seconda generazione.
Nello stesso racconto faccio un elenco delle cose che mi fanno sentire italiana e le cose che mi fanno sentire somala:
Vediamo un po’, mi sento somala quando: 1) bevo il tè con il cardamomo, i chiodi di garofano e la cannella 2) faccio le 5 preghiere quotidiane verso la Mecca 3) mi metto il dirah 4) profumo la casa con l’incenso o l’unsi 5) Vado ai matrimoni in cui gli uomini si siedono da una parte ad annoiarsi e le donne dall’altra a ballare, divertirsi, mangiare…..insomma a godersi la vita 6) mangio la banana insieme al riso, nello stesso piatto intendo 7) cuciniamo tutta quella carne con il riso o l’angeelo 8) ci vengono a trovare i parenti dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dall’Olanda, dalla Svezia, dalla Germania, dagli Emirati Arabi e da una lunga lista di stati che per motivo di spazio non posso citare in questa sede. Tutti parenti sradicati come noi dalla madrepatria 9) parlo in somalo e mi inserisco con toni acutissimi in una conversazione concitata 10) guardo il mio naso allo specchio e lo trovo perfetto 11) soffro per amore 12) piango la mia terra straziata dalla guerra civile 13) più altre 100 cose e chi se le ricorda tutte! Mi sento italiana quando: 1) faccio una colazione dolce 2) vado a visitare mostre, musei e monumenti 3) parlo di sesso, uomini e depressioni con le amiche 4) vedo i film dei seguenti attori: Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Totò, Anna Magnani, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Roberto Benigni, Massimo Troisi. 5) Mangio un gelato da 1.80 euro con stracciatella, pistacchio e cocco senza panna 6) Mi ricordo a memoria tutte le parole del 5 maggio di Alessandro Manzoni 7) sento per radio o tv la voce di Gianni Morandi 8) Mi commuovo quando guardo negli occhi l’uomo che amo, lo sento parlare nel suo allegro accento meridionale e so che non ci sarà un futuro per noi 9) inveisco come una iena per i motivi più disparati contro primo ministro, sindaco, assessore, presidente di turno 10) gesticolo 11) piango per i partigiani, troppo spesso dimenticati 12) canticchio un anno d’amore di Mina sotto la doccia 13) più altre 100 cose e chi se le ricorda tutte!
Credo che l’identità sia un mio tema centrale. Ma credo che in generale gli scrittori di seconda generazione non solo in Italia abbiano avuto questi problemi. Basta pensare ad un capolavoro dei nostri ultimi anni come Il Budda delle Periferie di Hanif Kureishi o alla simpatica protagonista di Denti Bianchi di Zadie Smith.
Quindi questa è una grande differenza tra me scrittrice di seconda generazione e tutti quei scrittori di prima. Loro sono approdati in Italia, l’hanno scelta, la loro identità è forse più definita della mia (ma non priva di crisi, anche se crisi diverse da quelle che ha potuto avere una persona con il mio stesso vissuto). Un’altra grossa differenza è l’uso della lingua. Per molti scrittori migranti usare l’italiano per scrivere è stata una scelta ponderata, sofferta, difficile. Sono stati accusati di tradire la madrepatria usando la lingua del NORD, sono stati beffeggiati per gli errori di grammatica dagli editor di turno, sono stati bersaglio di umiliazioni e cattiverie. Ma non hanno rinunciato. I primi scritti (come abbiamo visto in precedenza) sono stati scritti a quattro mani, un autore italiano era associato a quello migrante; ma poi si è provato a scrivere da soli….perdendo più tempo, facendo un lavoro enorme in fase di riscrittura e revisione, ma conquistando il diritto di esprimersi in una lingua non natale. L’italiano quindi è una scelta. Invece per me non lo è stata. Non riesco a pensare ad un’altra lingua per esprimere il mio pensiero scritto. Il somalo scritto (una lingua scritta recentemente, nata nel 1972) lo trovo lontano dalle mie corde e l’italiano è la lingua che uso per esprimermi in forma scritta. Anche a casa-dove parlo costantemente somalo con i famigliari- lascio i messaggi scritti in italiano. Quindi non ho scelto di scrivere in italiano, mi è capitato…..l’italiano per me è il corso naturale della mia scrittura. Ciò non toglie che arricchisco la mia scrittura con inserimenti di parole somale o arabe (tradizione religiosa) o bravane (il dialetto della città di mio padre: Brava. È una lingua bantù molto simile al swahili).
In più da aggiungere, nel caso mio, i forti legami tra Italia e Somalia. Essendo stato il mio paese d’origine Ex colonia italiana, ha conservato molti legami con la penisola, anche linguistici. Mio padre (che è stato addirittura Ballila da piccolo, quindi ha vissuto da vicino anche gli orrori del fascismo), mia madre, i miei fratelli hanno frequentato scuole italiane in Somalia. E spesso nella nostra famiglia i testi scritti erano veicolati in italiano.
La mia più grossa paura è ora essere ingabbiata in una etichetta, ossia Scrittrice migrante. Lo sono e non lo sono. Non mi piacciono le etichettature, perché quando penso alla scrittura migrante io penso a una scrittura che parla di immigrazione, ma non vorrei limitarmi a questo. Credo che gli autori migranti-di prima, seconda, incerta generazione-, che provengono da altri parti del mondo, non vogliano limitarsi a scrivere soltanto di immigrazione. Trovo che a volte parlare di migrazione possa diventare una gabbia. Personalmente vorrei parlare sia di migrazione, ma anche d’altro… a volte purtroppo noi autori di nascita non italiana siamo ingabbiati dalle nostre origini. Questa limitazione è molto forte, anche le case editrici che si avvicinano a noi, sono case editrici che si occupano di intercultura. Anch’io parlo spesso di immigrazione nei miei scritti, ma spesso mi ritaglio isole dove parlo di hobby per esempio (nel giornale Carta ho pubblicato dei mini-raccontini per raccontare l’amore per un hobby ai lettori….gli argomenti da me toccati sono stati vari: amore, solitudine, dilemma) o favole per ragazzi.
Certo l’anno scorso ho scritto anche un libro molto “migrante” per la casa editrice Sinnos nella serie I mappamondi. Il titolo del libro è La nomade che amava Alfred Hitchock, praticamente la storia della vita di mia madre, che è stata nomade prima di stabilirsi a Mogadascio e poi ora qui in Italia. Il nomadismo è una grossa componente della cultura somala. Lo scopo del libro è spiegare la Somalia ai bambini italiani e ai bambini immigrati in Italia, parlando di diversi temi, tra cui l’infibulazione, il colonialismo, la guerra civile, facendo vedere come i problemi di oggi sono stati i problemi di ieri.
Mi ha esaltato molto scrivere questo libro per ragazzi, ma la mia parola d’ordine ora è sperimentare. Vorrei conservarmi la libertà di scrivere di tutto e senza limitazioni. Ho ancora molto da imparare, la strada è tutta in salita ed è molto lunga.
Per Settembre prossimo ho pronto un libro sul meticciato, ma quello che vorrei spiegare è che non vorrei limitarmi a solo pochi temi. È logico che la dimensione “migrante” farà sempre parte del mio mondo (e non solo del mio, ma di tutti….la società è cambiata da tanto ormai); i miei personaggi saranno globali…ma quello che vorrei evitare sono le gabbie e le facili etichettature.
Credo che il fenomeno della letteratura migrante-di seconda, prima, incerta generazione-non è un fenomeno di moda, anzi ora più che mai sta ponendo le basi per le conquiste future.
Igiaba Scego





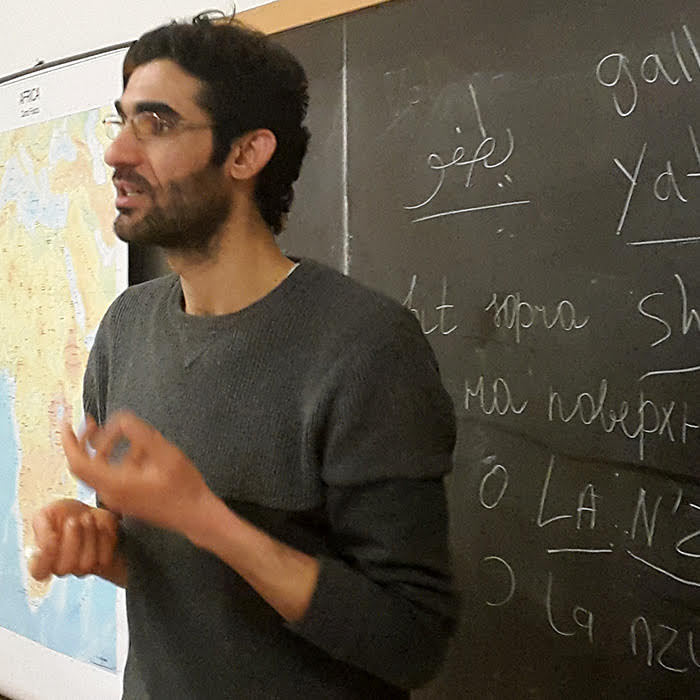
Condividi: